L'umiliazione nei filosofi cinici
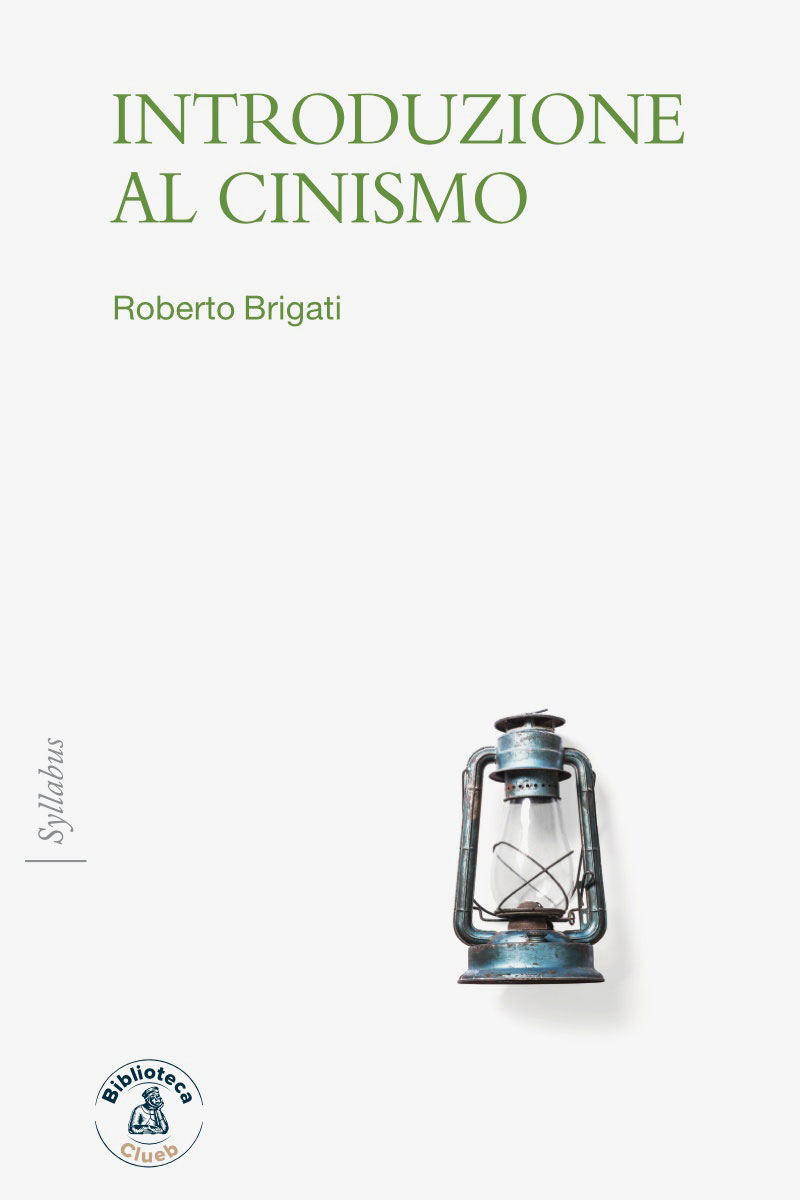
Nel libro Introduzione al cinismo, del professor Roberto Brigati, si legge che i filosofi cinici andavano attivamente alla ricerca del disprezzo e dell’umiliazione. Tale pratica è stata definita vilificazione. Disprezzo e umiliazione sono qualcosa che ognuno di noi cerca normalmente di evitare. Così, per capire se i cinici possano essere un esempio liberatorio da imitare oggi anche per noi, che ci roviniamo la vita con le nostre preoccupazioni di visibilità, status e approvazione, ho consultato la principale fonte sui filosofi cinici, Vite dei filosofi di Diogene Laerzio (da qui in poi, DL), e ho riflettuto con attenzione sulle frasi chiave del libro di Brigati. Il risultato a cui sono approdato è che, stando a questa fonte, i cinici non erano liberi dal bisogno di piacere e, più che cercare di essere umiliati, combattevano una battaglia, a volte carica di risvolti psicologici personali, per affermare un modo di vivere felici secondo valori in parte diversi da quelli della loro società.
“Introduzione al cinismo”: una filosofia improntata all’azione
Nell’epoca dei “like" sembra impossibile concepire che qualcuno possa darsi da fare per non piacere. Eppure nell’area che sarà occupata dall’impero romano, o perlomeno nei suoi centri culturali maggiori, a partire da Diogene di Sinope (412 a.C. circa – 323 a.C.), l’icona della filosofia cinica, e dal suo presunto maestro Antistene (allievo di Socrate), si è diffuso un atteggiamento ben riconoscibile verso la società e la vita che comprendeva anche la vilificazione. Nel rigoroso, avvincente e documentatissimo studio critico intitolato Introduzione al cinismo, del professor Roberto Brigati (2022), si legge che il movimento cinico è stato attivo fino alla fine dell’evo antico, con un numero di adepti che ha indotto Giovanni Reale a parlare di “fenomeno di massa”. Con il recupero umanistico della cultura antica ci sono stati “ripescaggi consapevoli, rivendicazioni ed emulazioni” in età moderna. Ed è concepibile che il retaggio inconsapevole sia proseguito fino alla modernità e alla contemporaneità.
Il comportamento cinico
I cinici cercavano lo scandalo, per una specie di resistenza passiva ai valori e ai costumi vigenti, la quale indicava una via per la felicità naturale dell’uomo, che non ha bisogno di orpelli e si basa anzi su una stretta limitazione dei propri desideri. Erano insolenti e attiravano intenzionalmente il biasimo. In generale non riconoscevano le convenzioni sociali, i confini politici, l’autorità, ed erano per una vita frugale vissuta nell’uguaglianza tra gli uomini e contro la schiavitù e le discriminazioni di genere.
Sebbene il cinismo sia considerato una corrente filosofica, per Brigati va inteso soprattutto come un modo di fare. Il cinismo è quindi una filosofia improntata all’azione: più che di concetti e principi, è fatta di comportamenti, che parlano da sé a chi vi assiste. I cinici, in generale, disprezzavano le aule1 e i testi scritti (benché ne abbiano anche prodotti; per es., DL attribuisce a Diogene saggi e tragedie) e il loro esempio mirava a dimostrare come fosse possibile vivere felici “secondo natura”, senza averi, riducendo i propri desideri e le proprie necessità, al di fuori della società e delle sue regole: alla maniera dei cani, da cui, secondo un’interpretazione, proverrebbe il nome. Infatti cinico significa canino, simile al cane, che imita il cane.
Il loro valore più alto era la libertà, che è possibile ottenere con una vita naturale, con pochi bisogni essenziali, rinunciando alle cariche pubbliche, alla gloria, alla ricchezza. Tale libertà si manifesta con una libertà di parola e una libertà di costumi. All’epoca dei primi cinici, scrive Brigati, “La cittadinanza, già orizzonte della libertà, è diventata un fardello e un freno alla libertà stessa, e quest’ultima evidentemente non è più intesa come la capacità di svolgere un ruolo all’interno di un corpo politico, ma come una condizione individuale, uno stato della mente” (p. 34). E poi “La libertà che cercano i filosofi è autarkeia, autosufficienza: non un diritto a partecipare alle decisioni pubbliche, ma a sperimentare una propria via estetico-morale alla saggezza” (p. 38).
I “cani” vivevano di elemosina2 e girovagavano a volte svestiti per le pubbliche vie, portando con sé pochissimi oggetti, annullando ogni confine tra vita pubblica e privata: pare infatti che a volte si accoppiassero in pubblico (per es., Cratete e Ipparchia), anche tra consanguinei, secondo i detrattori. Spesso chi li incontrava li guardava e li udiva scandalizzato e li biasimava. Molto di ciò che sappiamo degli oltre cento filosofi cinici documentati nel corso dei secoli proviene dalle invettive e dagli aneddoti dei detrattori.
Altri però restavano affascinati, ascoltavano i loro insegnamenti e seguivano il loro esempio, dopo essersi disfatti di tutti i loro averi, che spesso gettavano ritualmente in mare. L’ammirazione nei loro confronti ha dato origine a volte a ritratti aneddotici idealizzati e decisamente inverosimili. Secondo quanto scrivere Antistene nelle Successioni, i suoi amici credevano che fosse morto volontariamente trattenendo il respiro (DL VI.76).
I principi cinici
Quanto ai loro principi, DL li sintetizza come segue. Essi si dedicarono solo all’etica e bandirono l’istruzione enciclopedica in generale, la geometria, la musica e simili. Antistene – che secondo alcuni autori, ma non tutti, potrebbe essere stato il maestro di Diogene – era solito dire che coloro che hanno conquistato un equilibrio spirituale non devono studiare letteratura per non essere distratti da interessi estranei.
Essi ammettono che il fine supremo è vivere secondo virtù… in modo uguale agli Stoici perché v’è una certa affinità tra queste due scuole. Anzi, alcuni hanno definito il cinismo via breve alla virtù. E così visse anche Zenone di Cizio [il primo stoico, allievo del cinico Cratete, nda]. Sostengono che bisogna vivere semplicemente, mangiando cibi necessari al sostentamento e vestendo solo un mantello, disprezzando la ricchezza, la gloria, la nobiltà. Talvolta si cibano soltanto di erbaggi e in ogni modo bevono soltanto acqua fresca; basta un alloggio modesto, anche una botte. In una botte viveva Diogene, il quale era solito dire che è proprio degli dei non aver bisogno di nulla, di chi è simile agli dei aver bisogno di poco. Per i Cinici la virtù si può insegnare, come afferma Antistene nell’Eracle, né si può perdere una volta acquisita: il sapiente è degno di amore, infallibile, amico del suo simile, e nulla affida alla fortuna (DL VI.104-105, corsivi aggiunti)
Si dice che quando a un banchetto si gettarono delle ossa a Diogene come fosse un cane, lui andandosene ci orinò sopra (DL VI.46). Qui vediamo in azione un modo di reagire all’attacco che è non violento e spiazza l’aggressore. È come se Diogene dicesse: “Tu mi chiami cane e pensi di offendermi, ma per me il cane è un modello di vita! Noi stessi ci chiamiamo cinici”. Circa quattro secoli dopo, Epitteto, il cui stoicismo ha molti tratti in comune con il cinismo, suggerisce di rispondere a una critica dicendo una frase del tipo: “E questo non è neppure il peggiore dei miei difetti!” (2023).
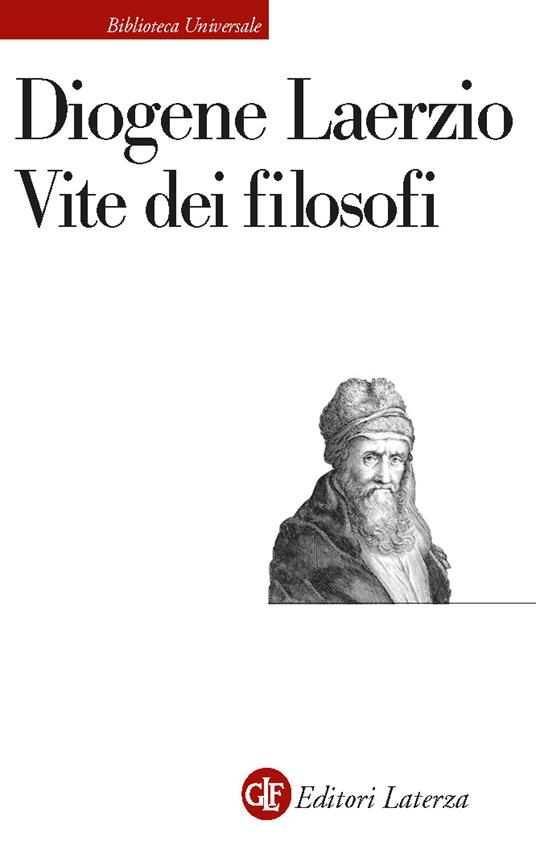
Per Brigati,
Che la buona reputazione non sia un indifferente ma una vera e propria illusione da combattere è indicato dal fatto che i cinici cercano attivamente l’opposto, il disprezzo, il ridicolo, se non l’umiliazione. … Se non riesci a sostenere l’umiliazione, se ti resta un mal riposto senso di dignità, se non ce la fai a farti zimbello, il cinismo non fa per te” (p. 164, corsivi aggiunti). La ricerca del disprezzo esibisce plasticamente l’illusorietà dell’orgoglio e contribuisce alla demolizione del posto privilegiato dell’anthrōpos come creatura più nobile (p. 165).
In questo scritto affermo che la lettura di DL non conferma questa visione. Io credo che non si possa parlare di generica ricerca del disprezzo, non più di quanto si possa parlare di ricerca del disprezzo per qualcuno che, per esempio, per affermare il valore della povertà entri e predichi a voce alta in un luogo in cui la gente va a fare spese pazze. I cinici della fonte da me consultata rifiutano certi valori, non tutti. E in generale Diogene cerca di non vergognarsi della propria personale condizione di esule, più che tentare una rivoluzione dei costumi. Diogene è molto orgoglioso e lo dimostra in tante occasioni. Più che cercare il disprezzo, è come se dicesse: “Non mi vergogno della mia condizione, tant’è vero che te la sbatto in faccia”. E a questo sbattere in faccia a volte gli altri reagiscono passando alle vie di fatto. Gli altri possono disprezzare, dileggiare e umiliare Diogene; lui in genere si esercita a non patire di ciò attraverso una trasmutazione di valori – o per operare tale trasmutazione – ma talvolta si offende e lo si deduce dal fatto che si vendica!
Aspetti psicologici del comportamento cinico
Brigati si astiene dal ricondurre la condotta apertamente provocatoria dei cinici a motivazioni psicologiche e a tratti psicopatologici, anche se accenna alla personalità di Diogene e al suo modo speciale di essere cinico. La collocazione storica della nascita del cinismo nel periodo della fine delle poleis, le città stato, può dare qualche indizio in questo senso a chi abbia buone cognizioni di storia della Grecia antica.
Nel fenomeno che Brigati chiama ricerca della vilificazione io vedo non solo l’espressione di un principio che sarà poi stoico, secondo cui non bisogna curarsi di cose che non sono sotto il proprio controllo, come l’opinione altrui, ma anche un insegnamento minore, una specie di corollario più persuasivo di quel principio generale, di cui potrebbe anche essere una fonte psicologica: non curarti dell’opinione di persone che tu stesso non apprezzi. Noi non teniamo in alcun conto la loro, perché è sbagliata e riflette valori e principi falsi (doxa). Quelli che credono di umiliarmi sono schiavi del desiderio di piacere, schiavi del denaro, del potere e dello status, a cui loro ambiscono. La loro offesa è prevedibile. Il disprezzo è reciproco. E poiché la massa tende a aderire a questi valori, sono poche le probabilità di sbagliare se si tiene in poco conto l’opinione di chiunque. Una persona disse ad Antistene: “Molti ti lodano”. Ed egli: “Che cosa, allora, ho fatto di male?” (DL VI.8). Sempre Antistene: “Meglio lottare con pochi buoni contro tutti i malvagi che con molti malvagi contro pochi buoni” (DL VI.12).
Non è questo l’atteggiamento di tanti adolescenti iconoclasti? “La società di voi adulti, che mi avete scaraventato in questo mondo schifoso senza che io lo volessi, mi disgusta. Siete infelici, siete delle marionette, gusci vuoti. Non vi occupate di ciò che conta veramente, non vi occupate di cercarlo, e sacrificate tutta la vostra triste vita al servizio di valori imposti dalla società. Vivete per lavorare invece di lavorare per vivere. Non siete felici. Siete schiavi di imposizioni e di convenzioni cui avete aderito acriticamente”.
Un atteggiamento simile potrebbe avere chi è alle prese con le domande esistenziali fondamentali ed è irritato dagli altri, in quanto apparentemente sereni nella loro incoscienza, come succede al protagonista del romanzo Il solitario di Eugene Ionesco o ad Antonio Roquentin de La nausea di Jean Paul Sartre.
Con la ricerca della vilificazione, quindi, il cinico potrebbe dire: “Io mi compiaccio della tua offesa perché essa dice chi sei. Guarda quali sono i tuoi valori, ciò che conta veramente per te”. È un momento di confronto di idee: “Io, con la mia indifferenza, ti dimostro che i tuoi valori non hanno nulla di necessario, sono opinabili, se non del tutto falsi. Tu al mio posto ti offenderesti. Io invece rimango indifferente. Lo vedi? Faccio quello che tu reputi ignobile e offensivo, e sorrido. Non mi curo del tuo onore e della tua dignità. Non è in queste cose che si misurano l’onore e la dignità”.
Tra le altre componenti psicologiche, c’è poi quella dell’abituazione alle avversità. In un episodio, citato da DL, per esempio, Diogene chiede elemosina a una statua per abituarsi a chiedere senza ottenere. Come osserva DL, “come quelli che sono avvezzi a vivere nei piaceri, malvolentieri passano ad un contrario tenore di vita, così quelli che si sono esercitati in modo contrario, con maggiore disinvoltura, disprezzano gli stessi piaceri” (DL VI.71).
Il peso dell’approvazione sociale
Dal test si guadagna… la possibilità di scoprire ciò che nella nostra vita può essere serenamente abbandonato, senza diminuire ma anzi accrescendo la felicità. Per rendersi conto di quanto siano superflue le cose che normalmente desideriamo, basta disfarsene e vedere che possiamo farne a meno. Lo stesso per i tabù sociali: una volta constatato che si possono abolire senza pericoli, si vede che sono illusioni (Brigati, p. 169).
La pratica della vilificazione è uno dei vari esercizi di resistenza – al freddo, al caldo, alla fame, agli attacchi verbali, alla paura – usati dai cinici per imparare e per insegnare a essere liberi. Brigati parla di “tecnica” a proposito della ricerca attiva del disprezzo e del ridicolo, se non dell’umiliazione, per combattere l’“illusione” della buona reputazione. In particolare sottoponendosi alla vilificazione cercavano di imparare a fare a meno dell’approvazione de “gli altri”, a essere liberi dal bisogno di piacere. L’espressione “bisogno di piacere” è una sintesi in cui comprendo il bisogno di attenzione positiva, di stima, di affetto, di simpatia. Parlo di attenzione positiva per distinguerla da un’attenzione negativa. È possibile che la vilificazione, in una sorta di perversione, sia in qualche caso un modo per ottenere attenzione, nella sua forma negativa, mediante un atto ostile, un richiamo, una critica, un insulto, dileggio, minacce, percosse. È noto che si può cercare attenzione in modo negativo, pur di non essere ignorati. Nella psicoanalisi, nel comportamentismo, nella teoria dell’attaccamento e nella psicologia dello sviluppo emerge un tema comune: gli esseri umani sono disposti a fare quasi qualsiasi cosa pur di non sentirsi invisibili. L’attenzione negativa è spesso un disperato sostituto dell’amore, della convalida e del riconoscimento.
Può darsi che gli stessi atti provocatori suscitassero sentimenti malevoli nei loro destinatari e sentimenti benevoli nei simpatizzanti o negli altri cinici. Questo è un aspetto molto importante perché allora la vilificazione pubblica attira dileggio, insulti, minacce ecc. da parte di alcuni ma stima, affetto e simpatia da parte di altri. E così l’esercizio di liberazione dal bisogno di approvazione avrebbe come effetto sociale anche quello di segnare una distinzione tra in-group e out-group.
Per imparare a non farsi condizionare dal desiderio di piacere, i cinici attiravano le reazioni opposte a quelle che esprimono gradimento, stima affetto, simpatia ecc. Il contrario di “piacere agli altri” è essere guardati male, essere allontanati, essere derisi, essere disprezzati, essere diffamati, essere umiliati, fino a essere percossi. Questo ci dice sicuramente una cosa: chi praticava questi esercizi sentiva il peso del proprio bisogno di piacere o suscitare sentimenti positivi. Ne sentiva il condizionamento quotidiano. “Disprezzato … il saggio raggiunge la perfezione dell’ascesi”! Quale libertà più alta della libertà dal bisogno di piacere? E quindi: quale bisogno più profondo, più irrinunciabile, di quello di piacere o di evitare di non piacere?
Nella ricostruzione storica di Brigati, si legge che il fenomeno della vilificazione sembra essere esistito sin dalla preistoria ed è attestato presso gli ājīvikas di Gosāla (Brigati, pp. 108-114). Inoltre “Ingalls (1962) ipotizza… che i cinici e i pāśupata abbiano avuto un’origine preistorica comune nel substrato indoeuropeo, osservando somiglianze con pratiche di autodegradazione e imitazione animale presenti nello sciamanesimo centroasiatico, in Scizia e il Tracia” (ivi, p. 112).
In una società di cacciatori-raccoglitori, quali sono stati gli Homo Sapiens-Sapiens fino a circa 10.000 anni fa, essere esclusi dal gruppo equivale a rischiare la morte (Music, 2018; Harari, 2018). Nessun contemporaneo probabilmente ha coscienza di questo pericolo nel momento del rifiuto o dell’esclusione subiti, ma sullo sfondo, nel suo inconscio, potrebbe esserci questo timore. In altre parole potrebbe avere agito un meccanismo selettivo per cui le persone che non si curano dell’opinione degli altri, dei sentimenti altrui nei loro confronti, tendono a morire senza lasciare prole.
Naturalmente però sul piano soggettivo il bisogno di piacere può trasformare la vita in un inferno, come sanno coloro che soffrono della cosiddetta ansia sociale o semplicemente di timidezza. A partire dagli anni Sessanta, lo psichiatra, psicoanalista e poi padre della Terapia Razionale Emotiva Albert Ellis prescrive ai suoi pazienti che soffrono di ansia sociale, timidezza o inibizione sociale vari esercizi antivergogna (shame-attacking) consistenti, per esempio, nel passeggiare per le strade di New York, dove lui operava, con una banana legata a una corda (per es., Ellis e MacLaren, 2005), qualcosa di sostanzialmente identico a ciò che fece il cinico Cratete con Zenone secondo DL: “pur essendo molto portato per la filosofia, era troppo riservato per poter adattarsi all’imprudenza dei Cinici. Cratete, volendo correggerlo anche in questo, gli diede una pentola piena di passato di lenticchie da trasportare attraversando il Ceramico” [Brigati, p. 164]. Portare del cibo in giro per la piazza, spiega Brigati, è lavoro da schiavi e se non riesci a sostenere l'umiliazione, se ti resta un mal riposto senso di dignità, se non ce la fai a farti zimbello, il cinismo non fa per te.
Paradossalmente il cinico, che si spinge all’ascesi pur di essere libero, resta comunque dipendente dalla simpatia altrui in modo esplicito e diretto nel suo vivere di elemosina. Avendo trasformato la sua vita in uno spettacolo continuo ha buone probabilità di riuscire a piacere a qualcuno: l’importante è che si parli di lui, come avviene alla gente che oggi ottiene la notorietà e con essa il denaro facendosi notare con ogni mezzo su YouTube. È alla ricerca continua di attenzioni.
Non sempre Diogene fu coerente nella ricerca della vilificazione in forma di percosse – o, per meglio dire, le reazioni alle percosse sembrano dimostrare che l’aggressione fisica non era ciò che cercava. Nei Detti sentenziosi Metrocle racconta che Diogene, dopo essere stato picchiato in seguito a una provocazione, anziché essere soddisfatto, si vendicò attirando sugli autori della violenza il disprezzo di altre persone (DL VI.33). Lo stesso fa anche Cratete quando viene picchiato per avere provocato il citaredo Nicodromo: anche lui va in giro con la faccia pesta e il nome di chi l’ha picchiato scritto in fronte (DL VI.89). Diogene e Cratete non vogliono essere umiliati veramente: probabilmente vogliono solo attirare l’attenzione per poi ingaggiare un duello verbale, sicuri di vincerlo. Come capiterebbe a ogni uomo comune al posto loro, dopo essere stato picchiati sono offesi e risentiti. Non sono Gesù, che porge l’altra guancia, o un anacoreta, un asceta eremita che accetta “la riduzione a uno status quasi cosale, che supera in radicalità anche l’autosufficienza cinica” (Brigati, p. 196).
E quanto a coerenza, pur essendo Diogene per l’uguaglianza tra gli esseri umani, “Quando ad Olimpia l’araldo proclamò: ‘Diossippo vince gli uomini’, ‘Costui – interruppe Diogene – vince schiavi, io uomini’” (DL VI.43) dove evidentemente in qualche modo ripropone l’idea che lo schiavo sia qualcosa di meno di un uomo.
La mia opinione è che, mediante la vilificazione, i cinici cercassero di imparare a subordinare l’apprezzamento di sé all’adesione a valori diversi da quelli della gran parte della società. In questa operazione perdevano la stima di alcuni e guadagnavano la stima di altri – tra cui gli altri cinici e sé stessi. Forse, attraverso i principi e le pratiche del cinismo, nasceva in alcuni di loro una particolare forma di autocoscienza etica, con l’idea stessa della relatività dei valori e dei codici etici. È possibile immaginare una vilificazione cinica “inversa”. Un cinico poteva in linea teorica essere dileggiato, disprezzato, umiliato o percosso dagli altri cinici, poniamo il caso, per il suo servilismo verso un ricco o un potente, o per il suo pudore o attaccamento ai beni materiali.
Il bisogno di autostima e la trasmutazione dei valori
Affinché un gesto possa essere veramente umiliante per chi lo compie, esso dev’essere contrario ai suoi valori, non a quelli degli eventuali spettatori. Per esempio, affinché chiedere elemosina possa essere umiliante, occorre come minimo aderire al valore della ricchezza (“Non si deve sapere che ho bisogno di soldi, è vergognoso”) o a quello dell’indipendenza nell’acquisizione dei mezzi di sostentamento (“Io non chiedo niente agli altri, ce la faccio da me”). Diogene sembra non farsi scrupoli a mendicare e vivere in mezzo alla strada perché la ricchezza non è per lui un valore. Sembra avere invece un atteggiamento paradossale riguardo all’indipendenza: cerca la libertà suprema ostentando indifferenza al giudizio altrui, ma è dipendente dalla simpatia altrui, in modo esplicito e diretto, per il fatto stesso che vive di elemosina. La necessità l’avrà sicuramente indotto a cercare di vincere la vergogna.
Come osserva Luciano Parinetto (2001, p. 7), in nome della loro provocatoria assunzione in positivo della povertà, i cani dell’antica Grecia ardiscono opporre le esigenze della schietta natura alle convenzioni della società e delle sue leggi, che, come dimostrano, anche nella prassi, alienano l’uomo invece di farlo libero. E lo fanno, oltre che con la “scandalosa” loro prassi, anche con il linguaggio, che ne è una parte. Non solo usando senza limiti e senza pudori qualsiasi parola, cioè eliminando la censura di moralisti e benpensanti, ma valendosi dell’arma dei doppi sensi, che in loro è micidiale.
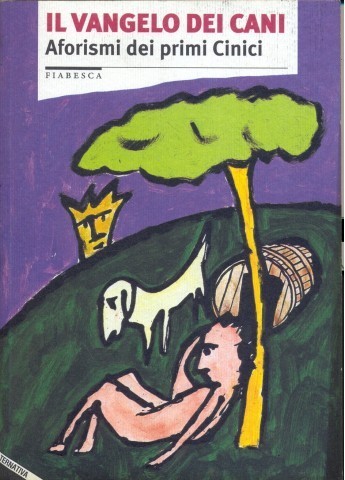
Vergogna e assenza di vergogna
Una volta [Diogene] vide un giovinetto arrossire, “Coraggio – gli disse – questo è il colore della virtù”. (DL VI.54)
Brigati esamina la presunta mancanza di vergogna che caratterizzerebbe i cinici. A suo avviso la “sfrontatezza” o assenza di vergogna (anaideia) cinica ha due dimensioni: la prima è “autarchica”, ovvero da connettere al valore dell’indipendenza e dell’autonomia; la seconda è “parresiastica”, cioè da rapportare al diritto-dovere della franchezza, che nei cinici arriva alla sfrontatezza, all’insolenza, alla provocazione. A proposito della dimensione autarchica, scrive che in primo luogo la vergogna (aidōs) è “una forma di dipendenza dallo sguardo altrui, eventualmente oggettivato sotto forma di principi interiorizzati”. Semmai, al contrario, la vergogna è una sorta di timore dello sguardo altrui, il quale sguardo può essere presente, essendo presenti degli osservatori nel momento dell’azione di cui ci si vergogna, oppure può essere interiorizzato.3 Questo timore rivela in effetti una sorta di “dipendenza”; per vergogna ci si può sentire costretti a fare o non fare una cosa che altrimenti si farebbe, ponendoci un limite ferreo che può essere molto fastidioso, può essere vissuto come un’odiosa schiavitù interiore. Quello che rivela è chi gli altri hanno un misterioso potere su di noi, con il loro semplice sguardo, o persino mediante la semplice contemplazione della possibilità che essi sappiano ciò che noi facciamo, senza neppure vederlo! Che sia possibile liberarsi dalla vergogna o meno è un aspetto che qui conta poco; perlomeno si può provare a ridurlo! E così hanno fatto presumibilmente alcuni cinici. Poi Brigati prosegue scrivendo: “E cedere al ricatto della vergogna è un venir meno all’imperativo morale della cura di sé: ‘Quando dai ascolto a un altro, non ti curi di te’.
Perciò la presa di coscienza cinica implica l’anaideia, l’abbandono di ogni pudore”. Io leggo “presa di coscienza” come percorso di perfezionamento etico. Qui l’interpretazione di Brigati sembra delineare una ribellione cieca, una estrema ricerca di libertà. Richiama molto l’individualismo imperante oggi nelle società occidentali.
Il mio pensiero e il mio desiderio valgono in quanto miei. Non devono avere contaminazioni esterne, a prescindere dal loro valore.
Questa libertà autarchica è palesemente una chimera. Sarebbe peraltro incompatibile con il ruolo di guida o maestro che i cinici hanno avuto verso i nuovi seguaci. Ma salta all’occhio soprattutto come sia la ricerca di una libertà da sé stessi, in quanto la vergogna è uno stato soggettivo sgradevole che si produce in modo del tutto involontario e difficilmente controllabile. Potremmo quindi sintetizzare l’aspetto autarchico dell’anaideia nel motto: non mi faccio limitare dagli altri (e da me stesso)! A chi disse a Diogene “Molti ti deridono”, lui replicò “Ma io non mi derido” (DL VI.55).
La seconda dimensione dell’anaideia è “il principio della non dissimulazione”, riprendendo la parole di Foucault. La spiegazione di Brigati è chiarissima: “non c’è ragione di nascondere ciò che non è male, e farlo tradisce la segreta convinzione che lo sia. Non si tratta quindi di infrangere le norme per puro antinomismo, ma di mostrarne l’incoerenza” (p. 162-163). Per la parte parresiastica dell’anaideia, quindi, il motto potrebbe essere: che male c’è?
Però Brigati osserva:”Non è però che il cinismo non si preoccupi delle reazioni del pubblico, e il dato interessante è che l’aneddotica se ne accorge e lo segnala, in testi in cui il cinico viene a sua volta smascherato nel suo esibizionismo” (p. 161, corsivo aggiunto). In vari aneddoti Platone rileva a ragione la vanità di Diogene (DL VI), un tratto che in quanto riporta DL è ben presente.
La mia tesi è che i cinici cercavano di non vergognarsi (di certe cose) e insegnavano ad altri a non vergognarsi (di quelle stesse cose). Per esempio, Cratete aiuta Metrocle a superare la sua vergogna: questi, fratello di Ipparchia, vuole morire per avere emesso un peto durante un’esercitazione scolastica, cosa che forse va a sommarsi alla mortificazione per la sua complessione debole. Cratete lo va a trovare e cerca di convincerlo che si è trattato di un fatto naturale inevitabile. Ma più delle sue parole vale il suo esempio: mangia lupini ed emette a sua volta un peto. Da quel momento Metrocle diventa un suo discepolo.
Ci sono altri esempi. Antistene avrebbe preso un sacco di farina senza pagarlo: un giovinetto gli promette che avrà cura di lui quando arriverà la sua nave carica di pesce salato; allora Antistene si fa accompagnare da una venditrice di farina, ne prende un sacco e le dice che pagherà il giovinetto. Diogene non trova strano rubare da un tempio, mangiare carne umana, masturbarsi e mangiare in luoghi pubblici. Un altro episodio: volendo dare una lezione a un tale che si vergognava di raccogliere un pezzo di pane cadutogli di mano, Diogene legò il collo di un vaso e lo trascinò attraverso il Ceramico (DL VI.35).
Tra le cose di cui incitavano a non vergognarsi o di cui cercavano di non vergognarsi, pur essendo riprovevoli nella loro società, possiamo annoverare: masturbazione e sesso in pubblico; mangiare in pubblico; vagabondare; usare un certo linguaggio; esprimere sempre la propria opinione; mancanza di istruzione; vestirsi e acconciarsi in modo trasandato o contrario ai costumi; chiedere carità e accettare doni; rubare; essere di condizione umile (anche se in questo non sono sempre coerenti).
Tuttavia non ritenevano che in generale la vergogna fosse un sentimento senza senso, da abolire, in quanto, per esempio, ogni condotta umana ha la stessa dignità di qualunque altra; infatti avevano una loro scala di valori, in parte sovrapposta a quella comune. Il cinico non combatte una battaglia contro il sentimento della vergogna, ma contro la vergogna di certe cose. Alcune cose di cui vergognarsi sono la codardia; la sconfitta; la debolezza; l’inettitudine; l’effeminatezza in un uomo; la condizione di schiavo e di servo; la mancanza di saggezza; la stupidità; la mancanza di rispetto per i genitori; la religiosità superstiziosa; attaccamento al denaro e alle cariche pubbliche.
In alcuni episodi, il cinico insegna all’allievo a non vergognarsi. Può farlo in almeno due modi: imponendogli di fare una cosa vergognosa (esperienza diretta) o eseguendo lui stesso un’azione vergognosa, per insegnare attraverso l’esempio (ciò che lo psicologo Alberta Bandura [2000] chiama modeling). In questi casi, in effetti, sembra che l’obiettivo della prova sia superare il sentimento della vergogna in generale, più che imparare a non vergognarsi di qualcosa per cui per i valori cinici non ha senso vergognarsi. Lo si deduce dal fatto che il compito antivergogna può essere insensato, come quello proposto da Albert Ellis ai suoi pazienti timidi o affetti da fobia sociale. Ellis usa una banana, Diogene usa un vaso da trasportare legato per il collo nel quartiere Ceramico. Nell’episodio in cui Cratete emette un peto davanti a Metrocle, invece, gli sta insegnando a non vergognarsi della flatulenza. E anche negli episodi citati da Brigati, l’insegnamento antivergogna è più legato a una specifica vergogna.
A questo punto però va fatta una precisazione. Albert Ellis (ignaro degli antecedenti stoici degli esercizi di shame-attacking; Robertson, 2020) non pensa che sia possibile estirpare il sentimento di vergogna, ma mira a insegnare a non passare dalla vergogna a un crollo di autostima generalizzato, come quello che colpì presumibilmente Metrocle: “nel 1968 ideai il mio ormai famoso esercizio di attacco alla vergogna; e forse milioni di persone, specialmente clienti di psicoterapia, hanno svolto questo esercizio e si sono allenati a provare vergogna o dispiacere per ciò che avevano fatto, e per la disapprovazione pubblica che spesso lo accompagnava, ma senza svalutare sé stessi e senza sentirsi umiliati nella propria persona” (Ellis e MacLaren, 2005, p. 95).
A volte i cinici hanno cercato di suscitare vergogna in altri – non solo a scopo didattico, per insegnare a liberarsene, bensì vendicativo o per ostilità, anche gratuita – e a volte hanno detto ad altri di vergognarsi. Antistene incita a vergognarsi un giovane che faceva da modello per un artista, perché si comporta come una statua di bronzo (DL VI.9). Diogene incita esplicitamente a vergognarsi, per esempio, un giovinetto effeminato, uno sciocco, un figlio che disprezza il genitore, un grazioso giovinetto che parla senza grazia (DL VI.65).
In definitiva, la forma di vilificazione cercata da Diogene mi pare meno radicale e generalizzata di quella descritta nel Pāśupata Sutra, databile al primo secolo d.C., ma basata su una tradizione più antica, che prescrive all’affiliato: “vilipeso si aggiri, soppressa ogni maculazione [evitando di sentirsi privo di dignità morale, nda]. Perché mal considerato dagli altri, dà maculazione a [cioè macchia, in senso morale, nda] coloro che lo disprezzano e si prende i loro meriti spirituali. Perciò, a mo’ di un morto, si aggiri, o russi, o si dimeni; o zoppichi; o amoreggi; agisca, insomma, e parli sconvenientemente di modo che ottenga il disprezzo (voluto). Disprezzato, infatti, il saggio raggiunge la perfezione dell’ascesi” (Brigati, p. 113).
Il senso della pedagogia della vilificazione
La pedagogia della vilificazione cinica sembra allora avere come obiettivo una sostituzione di valori.
Per Brigati, secondo i cinici la via più breve e insieme più dura per la saggezza, “è quella che passa per ciò che i cinici chiamavano askēsis, “esercizio”, “pratica”, e che comportava fra l’altro forme di annullamento dell’onore, delle pretese intellettuali e della sociabilità, fino al limite dell’animalizzazione. Questa è la “natura” come se la dipingono i cinici: una dismissione dei contenuti sociali, più che un ideale di perfezioni positiva” (p. 44-45). Però in DL io non trovo conferma di questo generale annullamento dell’onore, delle pretese intellettuali e della sociabilità. Non si tratta di annullamento dell’onore ma di spostamento dell’onore: si allontana dalle cariche sociali e dalla ricchezza per andare verso altri valori come il saper condurre una vita naturale. Alcuni valori non vengono toccati, come la superiorità degli uomini rispetto alle donne, dei liberi rispetto agli schiavi, degli uomini rispetto agli animali4, dei saggi rispetto agli stupidi, dei capaci rispetto agli incapaci, dei forti rispetto ai deboli, dei coraggiosi rispetto ai pavidi. Non vedo annullamento delle pretese intellettuali dato che l’intelligenza, la saggezza, la dialettica hanno sempre un valore elevato. La sociabilità è intesa in modo diverso: lungi dal non avere una vita sociale, Diogene era circondato di amici e discepoli, frequentava mense dimestiche e alla sua morte gli furono persino eretti monumenti (DL VI.78).
Diogene non cerca annullamento dell’onore, delle pretese intellettuali e della sociabilità, ma provoca. Il risultato del comportamento provocatorio di Diogene sarà il disprezzo e l’ostilità di una parte di società, controbilanciato dall’approvazione e dall’inclusione in un gruppo più ristretto. L’allievo che ha compiuto il percorso interiore, arriva a sentire l’orgoglio e l’onore che gli derivano dall’adesione ai nuovi valori, in particolare al valore della presunta indipendenza dall’approvazione altrui, in cui gli “altri” vanno intesi in senso ristretto come altri rispetto a noi cinici (o pāśupata o gimnosofisti di Taxil).
A volte la provocazione del cinico ottiene l’effetto di suscitare la stima della persona provocata – forse perché è condiviso il valore assoluto del coraggio – e il dileggio degli altri cinici. Lo storico Dionisio racconta che, dopo la battaglia di Cheronea5, Diogene fu catturato e condotto al re macedone Filippo II, che gli chiese chi fosse; lui replicò: “Osservatore della tua insaziabile avidità”. Per questa battuta fu ammirato e rimesso in libertà (DL VI.43). Accadde qualcosa di simile nel famoso incontro con Alessandro Magno raccontato da Plutarco, in cui Diogene disse al re: “Scostati un poco dal sole” (citato in Brigati, 2022). Alessandro fu così colpito e talmente ammirò la grandezza d’animo di quell’uomo che mentre i compagni che erano con lui, al ritorno, deridevano il filosofo e lo schernivano, lui disse: “Se non fossi Alessandro, io vorrei essere Diogene”. In un terzo episodio, un generale di Alessandro, Perdicca, lo manda a chiamare minacciando che se non fosse andato da lui l’avrebbe ucciso. E Diogene: “Nulla di straordinario: anche uno scarafaggio e una tarantola saprebbero fare questo” (DL VI.44).
.jpg)
Diogene dimostra molta audacia con la sua insolenza pubblica. Lo stesso Alessandro gli domanda se non abbia paura di lui (Diogene risponde di no, essendo Alessandro “un bene”). E si può presumere che fosse in cerca di ammirazione con le sue dimostrazioni. Che avranno detto i compagni che erano con lui nel mitico episodio dell’incontro con Alessandro che gli oscura il sole? Si saranno sbellicati dalle risa, si saranno dati di gomito commentando a occhi e bocca spalancata: “Hai visto che fatto?”. Ipotizzo che i suoi compagni possano avergli detto: “Sei proprio matto a rispondere così ad Alessandro, ti poteva ammazzare!”. Sfidando Alessandro, il più potente, prova a mettersi al suo livello, e gli va bene;6 perciò è interessato allo status che può derivargli dal pubblico duello verbale. Si dimostra altresì impavido davanti alla morte; anzi, dimostra che pur di essere ammirato è disposto a morire, un po’ come chi pratica gli sport estremi (Lo Iacono, 2024). Talvolta, osserva Brigati (p. 166), i cinici rovesciano l’adoxia, il rifiuto della buona reputazione presso la società, in vera gloria. “Volgendo Antistene la parte lacera del suo mantello in modo che fosse visibile a tutti, Socrate”, giustamente, “vide e disse: ‘Attraverso i fori del tuo mantello, vedo il tuo desiderio di gloria’” (DL VI.8). Musonio scrive che proprio ciò che per tutti è vergogna, cioè l’esilio, rende invece Diogene massimamente glorioso. E fin qui, quanto a valori, è simile alla massa.
La personalità di Diogene
Leggendone il ritratto fornito da DL, ho l’impressione che Diogene di Sinope sia stato assai arguto e non solo istruito abbastanza da poter fare da precettore ai figli di colui che lo acquista come schiavo, ma anche ricco di tutte quelle capacità e di quel senso pratico che si acquisiscono vivendo per strada, tra cui l’adattamento al rigore e alle ristrettezze e l’impassibilità davanti al pericolo e al dolore. Era estroverso fino alla sfacciataggine; orgoglioso,7 altezzoso, dominante; assai energico e vitale; abile nelle relazioni sociali, a persuadere gli altri; dotato di una perizia dialettica del tutto inedita e rivoluzionaria (Carbone, 2010), rapido nelle associazioni di idee e nelle risposte, capace di volgere a suo vantaggio, con questi mezzi e un pizzico di opportunismo, la difficile situazione di esilio in cui si trovava. Un provocatore indefesso, dotato di una visione per una società migliore che sembra recedere sullo sfondo rispetto ai suoi interessi personali. Verosimilmente portò con sé una buona dose di rabbia, per l’esilio da Sinope e la condizione di “bandito” ad Atene (dove arrivò presumibilmente tra i 20 e i 30 anni) e poi per quella di schiavo a Corinto. Spesso viene picchiato – e si vendica. Nonostante l’asprezza del suo carattere, godeva dell’affetto degli ateniesi (DL VI.44) e su qualcuno esercitava un fascino magnetico.

Brigati scrive che Diogene aggrediva solo persone che rappresentavano i valori contrari alla sua filosofia. In realtà leggendo DL si ha l’impressione che ne avesse per tutti, etere, fanciulli ed effemminati, gente inetta o stupida, atleti e che aggredisse verbalmente anche per capriccio, per la sua natura polemica e provocatrice. In generale era una persona aspra e sarcastica. A volte il suo sarcasmo è feroce e gratuito: “una volta vide il figlio di un’etera lanciar sassi contro una moltitudine e l’ammonì così: ‘Attento a non colpire tuo padre!’“ (DL VI.62). La maggior parte degli aneddoti riportati da DL riguarda comunque battute di spirito, spesso doppi sensi, che sono piaciute tanto da essere state tramandate per secoli e secoli.
Si potrebbe ipotizzare che l’aspetto dell’anaideia, assenza di vergogna, sia stato enfatizzato da Diogene anche per ragioni legate alla sua vicenda individuale. A seconda delle versioni, Diogene è scappato o è stato esiliato da Sinope, probabilmente per una vicenda connessa alla contraffazione di moneta da parte del padre banchiere, Icasia, a cui potrebbe aver partecipato lui stesso (Giannantoni, 1990). DL riporta che era deriso per la sua condizione di esule e di mendicante, cosa che sembra non essergli stata indifferente. Del resto, i principi etici fanno presa specialmente quando aiutano effettivamente a vivere meglio. A questo proposito, a chi gli rimproverava l’esilio, rispose: “Ma è per questo, o disgraziato, che mi diedi alla filosofia” (DL VI.49).
Essendo orgoglioso, Diogene potrebbe avere provato una vergogna intollerabile per la propria condizione di esule nullatenente e randagio,8 e magari anche per le ragioni che avevano portato al suo esilio, e che (anche) per questo si sia spinto a “fare del vizio una virtù”, mettendo in atto meccanismi di razionalizzazione. DL scrive che era bravo nel trattare gli altri con estrema alterigia (DL VI.24).
Esprimeva giudizi negativi più o meno su tutti e in particolare era in aperta competizione con Platone che di rimando gli rivolge varie critiche tra cui quella di non avere una mente (DL VI). Come afferma Musonio, citato da Brigati (p. 166), Diogene trasforma l’esilio, ciò che per tutti è vergogna, in gloria. Si profilerebbe così una soluzione narcisistica al problema di mantenere alta la propria autostima (vedi per es., Gabbard e Crisp, 2019). I cinici successivi potrebbero avere quindi recuperato la sua lotta personale contro la vergogna per un misto di ragioni “dottrinali” e di ragioni psicologiche. A nessuno piace vergognarsi, e quasi chiunque si dice “timido”, anche chi dall’esterno non sarebbe affatto giudicato tale, a testimonianza di quanto sia fastidioso il limite interiore posto dalla vergogna, dall’imbarazzo (Zimbardo, 1977).
Come osserva Cimatti (2022) il gesto cinico ha sempre bisogno, per potersi realizzare, di una istituzione da destituire. Senza Alessandro Magno, non avrebbe senso nemmeno la figura di Diogene: “È per questo che i cinici restano personaggi urbani e mondani, non eremiti” (Brigati 2022, p. 173). Là dove c’è un’istituzione, di qualunque tipo, c’è uno spazio possibile per un gesto cinico. Brigati scrive “Non si pensa da cinici: si è cinici o non lo si è” (p. 56). Cimatti gli fa eco: il cinico è un provocatore. Un rompiscatole che a volte viene picchiato.
Conclusioni
Come ho argomentato, ciò che Brigati descrive come vilificazione, ricerca attiva del disprezzo e del disonore, nelle notizie biografiche riportate da DL sui cinici, è una pratica di esercizio (askesis) ad allontanarsi da certi valori per andare verso altri valori sottoponendosi al rifiuto di alcune persone e ottenendo l’adesione, la stima, la fedeltà di molte altre.
Le motivazioni psicologiche alla base della ricerca della vilificazione andrebbero cercate per ogni singolo individuo ed episodio, conoscendo l’esatta dinamica della situazione e la storia del protagonista e qui si accennato solo a qualche possibile motivo. C’è da chiedersi se sia possibile rinunciare del tutto all’apprezzamento di chiunque. La vita in questo rischierebbe di diventare solitaria e molto difficile da sostenere. I cinici come minimo sono piaciuti a chi li ha imitati e probabilmente a chi ha elargito loro elemosina di cui hanno vissuto. Sicuramente erano persone sicure delle proprie idee e ci hanno lasciato un buon esempio di indipendenza di giudizio e capacità di limitare i propri desideri e vivere con poco. Un esempio prezioso in un’epoca caratterizzata dalla forte diffusione dei social media, da forti pressioni al conformismo e preoccupazioni di sostenibilità.
Bibliografia
- Bandura A. (2000), Autoefficacia. Teorie e applicazioni, Erickson, Trento.
- Brigati R. (2022), Introduzione al cinismo, Clueb, Bologna.
- Carbone A.L. (2010), DIOGENE DI SINOPE. Filosofia del cane, :duepunti edizioni, Palermo.
- Cimatti F. (2022), Il gesto cinico, “Fata Morgana web”, 17 Aprile 2022.
- Ellis A. e MacLaren C. (2005), Rational Emotive Behavior Therapy: A Therapist’s Guide, Impact Publishers.
- Epitteto (2023), Tutte le opere, Bompiani, Milano.
- Gabbard G.O. e Crisp H. (2019), Il disagio del narcisismo, Cortina, Milano.
- Giannantoni G. (1990), Socratis et socraticorum reliquiae. Volumen IV, BIBLIOPOLIS.
- Harari Y. N. (2018), Sapiens. Da animali a dei, Bompiani, Milano.
- Lo Iacono G. (2024), Psicologia degli sport estremi. La vita nelle mie mani, Calzetti e Mariucci, Torgiano.
- Music G. (2018), La vita buona. Origini dell’altruismo, dell’empatia e della moralità, Borla, Roma.
- Parinetto L. (a cura di) (2001), Il vangelo dei cani. Aforismi dei primi cinici, Stampa Alternativa.
- Robertson D. (2020), The Philosophy of Cognitive-Behavioural Therapy (CBT). Stoic Philosophy as Rational and Cognitive Psychotherapy, Routledge.
- Zimbardo P.G. (1977), Vincere la timidezza, Geo, Milano.
-
Sul fatto che Diogene, secondo Brigati, non fosse impegnato in un insegnamento formale: DL parla di sue “lezioni” (DL VI.76). ↩
-
Non tutti. Per es., il cinico Menippo, prestando denaro a giornata diventò molto ricco. Quando fu derubato di tutti i suoi averi, “rinnegando la sua natura di cane, s’impiccò” (DL VI.100). ↩
-
Il riferimento ai principi restringe indebitamente la sfera dei fenomeni che spieghiamo in termini di vergogna; si può provare vergogna, per esempio, nel conversare con una persona estranea o nel parlare in pubblico, senza sentire di violare con questi atti alcun principio. Potrebbe avere avuto ragione Agostino (citato da Brigati, 2022, p. 163) a chiamare “naturale” quella componente del pudore che neppure i cinici avrebbero potuto estirpare da sé, nonostante le loro provocazioni. ↩
-
Per quanto Diogene prenda a esempio il cane e il topo, tra gli altri animali, intende ancora come offesa paragonare qualcuno a un animale. Per esempio, “Mentre faceva colazione nella piazza del mercato, la gente che gli era intorno ripeteva: ‘Cane’; e Diogene: ‘Cani siete voi che mi state attorno mentre faccio colazione’” (DL VI.61). Qui è evidente l’intento di restituire l’offesa. ↩
-
Che nel 338 a.C. sancì la fine dell'indipendenza delle poleis e l'ascesa del regno di Macedonia sotto il re Filippo II. ↩
-
In realtà un allievo di Diogene, Onesicrito, accompagna Alessandro in India. E, secondo Diocle, Alessandro abitò un giorno nella casa di Cratete, altro filosofo cinico allievo di Diogene, come in quella di Ipparchia abitò Filippo (DL VI.88). Pertanto, il cinismo godeva probabilmente della stima di Alessandro. ↩
-
Quando venne condotto a Creta dai pirati e venduto come schiavo, riporta DL, un banditore gli chiese cosa sapesse fare e lui rispose: “Comandare agli uomini”. Accennandogli poi un tale da Corinto, pomposamente vestito disse: "Vendimi a colui; egli ha bisogno di padrone”. Al suo compratore Seniade intimava di obbedirgli, anche se schiavo. Strano per una persona che disprezza il potere; o forse no, potevano essere provocazioni efficaci per i valori delle persone che aveva intorno. Platone gli dice: “Di quanto orgoglio trasparisci, pur volendo apparirne immune!” (DL VI.26). ↩
-
Anche se, secondo Seneca, “senza che nessuno lo avesse costretto – si diceva – aveva intrapreso una vita difficile, di isolamento, mettendosi alle strette con le sue stesse mani poiché aveva rinunciato spontaneamente a ogni ricchezza” (Carbone, 2010, pp. 20-21). All’arrivo ad Atene, Mane, il suo schiavo o servo, a seconda delle traduzioni, scappa, e lui non cerca di recuperarlo. ↩
