Io sono il silenzio dei segreti: la Bhagavadgītā
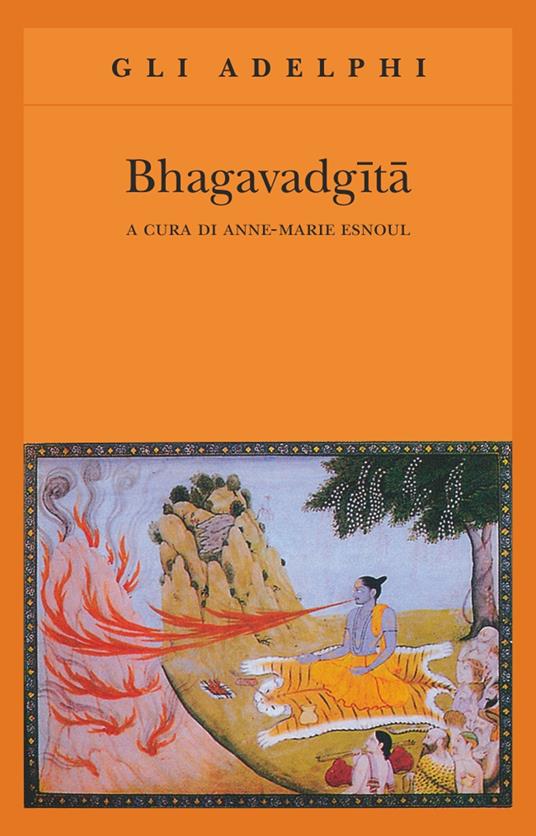
La Bhagavadgītā è il cuore del Mahābhārata, il più lungo poema epico che sia mai stato composto, con sei milioni di strofe, in cui si narrano le vicende eroiche delle famiglie regali della pianura del Gange al primo insediarsi delle stirpi degli Ārya, portatrici di una lingua indoeuropea, il sanscrito, e d’una cultura di cui i Veda ci forniscono un’immagine fedele.
Non siamo a conoscenza né dell’epoca né della forma in cui il Mahābhārata fece originariamente la sua comparsa (Piantelli, 1976, p. 182), ma secondo J.A.B. van Buitenen, che lavorò a lungo alla più autorevole edizione occidentale, va considerata una biblioteca di opere scritte da vari autori a più riprese tra il 400 a.C e il 400 d.C.
La Bhagavadgītā è un dialogo tra l’uomo Aryuna, un re degli Ārya, e Dio. L’uomo è in un momento particolarmente difficile della sua vita: si trova in preda all’angoscia su un campo di battaglia dove sta per svolgersi un combattimento fratricida. Pur di non uccidere, sarebbe disposto a morire, sicuro che la sua coscienza lo perseguiterebbe in eterno. Chiede allora consiglio a Dio, incarnato nel suo auriga, Krsna. Cosa è giusto fare? Che cosa vorrebbe Dio da lui? Poiché le risposte non sono chiarissime, l’uomo continua a chiedere delucidazioni. Così viene esposta un'intera versione del Bramanesimo, ricchissima di imprescindibili riferimenti ai Veda e alle Upanishad.
Quando io penso a Dio, non so mai che cosa immaginare. Per forza, mi spiega la Bhagavadgītā, riportando le parole di Dio. Ogni cosa io conosca, viene da Dio, è una delle sue infinite emanazioni, ma Dio ne è solo l’origine, non l'immagine. Qualunque cosa io conosca attraverso i miei sensi, si trova in uno spazio e in un luogo ed è inserita in una catena infinita di cause ed effetti. Per avvicinarmi alla conoscenza di Dio devo invece abbandonare:
- La distinzione tra soggetto e oggetto della conoscenza: “Tu sei il Soggetto conoscente, l’Oggetto da conoscere e la Sede suprema” (XI.38)
- La forma del principio di causalità: “io stesso produco me stesso” (IV.7); “il Signore del mondo non produce né lo stato di agente, né gli atti, né il legame tra gli atti e i loro frutti. Ma è la spontaneità della natura a operare” (V.14)
- La forma del tempo: “io rimango al di sopra dell’azione e del mutamento” (IV.63)
- Il concetto di agentività: “Colui che vede che gli atti sono prodotti dalla natura, e altresì che il Sé non è agente, quegli vede giusto” (XIII.29).
Essendo Dio “il tutto”, è possibile affermare: “Il Brahman è il suo atto oblatorio, il Brahman la sua oblazione versata dal brahmàn nel fuoco che è Brahman. Deve certo andare al Brahman colui che si concentra sull’atto sacrificale che è Brahman” (IV.24) o anche “Mediante questa conoscenza tu vedrai tutti gli esseri, tutti, senza eccezione, nel Sé, cioè in me” (IV.35). Il soggetto, insegna la Bhagavadgītā, può imparare ad annullarsi nel tutto, e con questo sparisce la distinzione tra azione (interessata) e non azione, dal momento che spariscono il desiderio e la meta.
Le vie per fare la volontà del Signore supremo sono varie: la speculazione sui fondamenti del reale (sāṃkhya), l’agire in stato di unità interiore (karma yoga), la contemplazione yogica, i sacrifici, le austerità, la virtù.
Di questa lettura mi hanno colpito in particolare due cose. La prima è la capacità di trasmettere, paradossalmente, l’esperienza di Dio. In molte parti del libro, ma in particolare nel Canto IX, l’uso di parole poetiche permette di fare un’esperienza viva della fede in Dio, trasmettendo l’inconcepibile, ciò che non può essere detto, ciò che è senza qualità e non è ancora manifestato, ma che è origine di tutte le cose e sua destinazione finale, ciò che è senza spazio e senza tempo, ciò di cui ogni cosa, nella sua finitezza e particolarità, è manifestazione parziale - ciò di cui in definitiva si può parlare quasi solo per negazione o mediante splendide metafore e analogie, come “io sono il silenzio dei segreti”.
La seconda è la prospettiva etica, tema per cui ho un costante interesse. In una strofa, che ne offre una sintesi, la virtù è chiamata semplicemente “conoscenza”:
Praticare modestia, franchezza, non-violenza, pazienza, rettitudine, servizio pio del maestro, purezza, costanza, padronanza di sé, distacco dagli oggetti sensibili e distacco dall'io, constatare le deficienze e i mali inerenti alla nascita, alla morte, alla vecchiaia e alla malattia, astenersi dall'attaccamento che rende appassionatamente legati a figli, sposa, casa o qualsivoglia altro possesso, mantenere una costante equanimità di fronte agli avvenimenti, siano essi in accordo o in disaccordo con i nostri desideri, dedicarsi senza infrazioni alla devozione verso la mia persona, a esclusione di ogni altro legame, ricercare i luoghi ritirati, con disgusto per la società degli uomini, applicarsi in modo permanente alla conoscenza di sé, avere l'intuizione di ciò che significa la conoscenza del reale, ecco ciò che si proclama conoscenza e quanto se ne discosta è la non-conoscenza (XIII, 7-8-9-10-11).
Mi pare di riconoscere nelle virtù sattviche qui compendiate la sostanza degli insegnamenti di Epitteto.
Il messaggio della Bhagavadgītā sulla specifica domanda iniziale di Aryuna, combattere o non combattere?, sembra però racchiudere una contraddizione (perlomeno ai miei occhi): se tra le virtù elencate figurano la non-violenza (e altrove nel testo, si parla della liberazione dall’odio, che è figlio del desiderio), la modestia e il distacco dall’io, non capisco come Krsna possa dire ad Aryuna: “Conquista la gloria, trionfando sui tuoi nemici. Godi di un regno prospero” (XI.33). Per quanto dopo aggiunga “È da me che sono stati dapprima votati alla morte. Siine lo strumento e niente più”, Krsna fa leva sulle ambizioni egoiche di Aryuna, cioè sulla sua fame di gloria personale. E psicologicamente mi sembra impossibile combattere con la spada “senza mettere nulla di personale”, senza odio nei confronti del nemico, e farlo, così, perché l’ha voluto Dio.
Piantelli M. (1976), Nota sulla “Bhagavadgītā”. In Bhagavadgītā, Adelphi, Milano, p. 182
